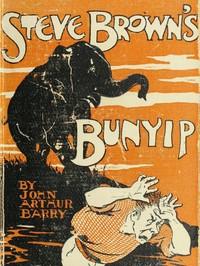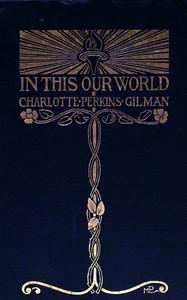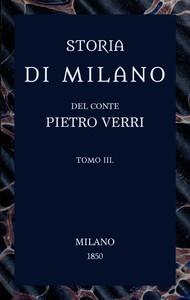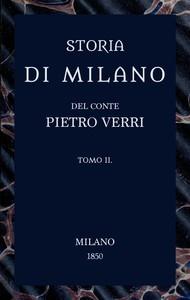Read this ebook for free! No credit card needed, absolutely nothing to pay.
Words: 118359 in 15 pages
This is an ebook sharing website. You can read the uploaded ebooks for free here. No credit cards needed, nothing to pay. If you want to own a digital copy of the ebook, or want to read offline with your favorite ebook-reader, then you can choose to buy and download the ebook.
STORIA DI MILANO
DEL CONTE
PIETRO VERRI
COLLA CONTINUAZIONE
MILANO PRESSO IL LIBRAIO ERNESTO OLIVA Contrada de' Due Muri, N. 1044 1850
Mentre era Monza bloccata e abbandonata in preda alla violenza che usavano questi avanzi di un'armata collettizia, i canonici di San Giovanni di quel borgo avevano somma inquietudine che le rapine non si estendessero sopra del pregevolissimo tesoro della loro chiesa; il quale allora, siccome dissi, era valutato ventiseimila fiorini d'oro, oltre il pregio delle cose sacre antiche. Deputarono quindi quattro canonici del loro ceto, ai quali commisero di pensare a un sicuro nascondiglio, ed ivi riporlo. Fecero giurar loro un inviolabile secreto, da non rivelarsi se non in punto di morte. Poich? da essi fu eseguita la commissione, e il tesoro collocato, non si sapeva dove, il capitolo obblig? i quattro depositari del secreto a partirsene, e separatamente frattanto vivere altrove; acciocch? non potesse colle minacce, e fors'anco colle torture, costringersi alcun d'essi a parlare, e in potere di que' licenziosi non rimanesse alcun presso cui fosse il secreto. Pensare non si poteva pi? cautamente, eppure Monza perdette il tesoro. Uno de' quattro canonici, che aveva nome Aichino da Vercelli, stavasene in Piacenza, ove venne a morte, e pales? il secreto a frate Aicardo, arcivescovo di Milano. Da esso ne fu bentosto informato il vigilantissimo cardinale legato, Bertrando del Poggetto; il quale non perd? tempo, e incaric? Emerico, camerlingo di santa Chiesa, che trovavasi in Monza, di trasmettergli quel tesoro, siccome esegu? puntualmente, e indi fu trasportato in Avignone, dove dimorava il papa, d'onde, venti anni dopo, signoreggiando Luchino, venne restituito l'anno 1344. Io lascer? al chiarissimo signor canonico teologo don Antonio Francesco Frisi la cura di verificare se la restituzione siasi fatta senza alcuna perdita. Il valore dell'oro e delle gemme che oggid? ivi si mostrano, non giunge fors'anco a duemila fiorini d'oro. Egli, che con varie dissertazioni ba illustrate le antichit? di Monza, ci render? istrutti esattamente anche di ci? nella dissertazione che si ? proposto di pubblicare sul tesoro di quella chiesa.
Della improvvisa morte di Stefano Visconti varie sono le opinioni degli autori; alcuni attribuendola a veleno, altri ad eccesso di vino; tutti per? sono d'accordo nel riconoscerla improvvisa. Il mausoleo di Stefano vedesi nella Chiesa di sant'Eustorgio, nella cappella di san Tommaso d'Aquino; lavoro il quale probabilmente si fece verso la met? del secolo decimoquarto. Poich? allora, oltre l'incertezza nella quale trovavasi la signoria de' Visconti, anche l'interdetto avr? impedito questi onori funebri; molto pi? a Stefano Visconti, scomunicato, perch? figlio di Matteo, quantunque egli non abbia mai avuto parte nel governo dello Stato e nelle dispute col papa. Quel mausoleo merita d'esser osservato, per avere idea della magnificenza de' Visconti in que' tempi; e in quella chiesa medesima merita pi? d'ogni altra cosa osservazione il nobilissimo deposito di marmo cui stanno le reliquie di san Pietro martire; opera che ? delle prime e delle pi? antiche per servire d'epoca al risorgimento delle arti, e da cui si pu? conoscere quanto fossero gi? onorate e risorte verso la met? del suddetto secolo decimoquarto. Le figure e i bassorilievi sono di un'artista pisano, che travagli? con una maestria e grazia affatto insolita a' suoi tempi.
Azzone Visconti, unico figlio di Galeazzo I e di Beatrice d'Este, era diventato, siccome dissi, vicario imperiale, al prezzo di sessantamila fiorini d'oro. Ma poich? egli fu rappacificato col sommo pontefice , il titolo di vicario eragli di nessun uso; perch? dato da chi non poteva pi? considerarsi da Azzone come munito della facolt? di concederlo. Perci? egli ottenne la signoria di Milano dal consiglio generale della citt?, il giorno 14 marzo 1330; e cos? si ritrov? sovrano e principe senza contrasto alcuno. Azzone veramente meritava d'essere il primo della sua patria; e gi? mentre signoreggiava Galeazzo I, di lui padre, s'era guadagnato un nome distinto nella milizia, avendo egli acquistato borgo San Donnino, aiutato il Bonacossi a battere i Bolognesi, ed assistito Castruccio Antelminelli a battere i Fiorentini. Azzone in quest'incontro non dimentic? di far correre il palio sotto le mura di Firenze, per bilanciare il trattamento che i crocesegnati fiorentini avevano fatto, due anni prima, ai Milanesi. Allora fu che egli acquist? la stima e l'amicizia di Castruccio; il che poi fu cagione per cui egli e il padre e gli zii riacquistarono, siccome dissi, la libert?.
La gloria e la felicit? di Azzone erano un tormento atroce nell'animo di Lodovico, ossia Lodrisio Visconti, cugino in quarto grado del principe. Lodrisio era buon soldato; pareva che fosse trasfusa in lui l'anima orgogliosa e forte di Marco. Gi? vedemmo come Lodrisio fosse celato in sua casa da Matteo, nel giorno in cui scoppi? la sollevazione contro del re Enrico. Veduto pure abbiamo come Matteo gli avesse dato il comando di Bergamo. Morto che fu Matteo, nessun caso pi? si faceva di Lodrisio. Lo Scaligero, signore di Verona, aveva licenziata una di quelle compagnie militari che prendevano in quei tempi servizio indifferentemente; e che pronte erano ad uccidere e devastare dovunque, in favore di chi voleva pi? pagarle. Lodrisio assold? questa truppa, per tentare il colpo di scacciare il cugino, e collocarsi sul trono. Entr? nel milanese e fece guasto largamente; e coll'improvvisa intrusione, sbigott? e sorprese. Ma Lodrisio aveva preso a combattere contro di un principe che era buon soldato e che era amatissimo da tutti i sudditi. Nobili, popolari, tutti a gara corsero intorno di Azzone; cercando quanti erano capaci di portare armi, di combattere volontari per lui. Lodrisio si era attendato a Parabiago, e la sua armata era composta di duemila e cinquecento militi, ciascuno de' quali aveva due altri combattenti a cavallo di suo s?guito; in tutto settemila e cinquecento cavalli. Aveva di pi? un buon numero di fanti e di balestrieri; il che formava un corpo d'armata poderosa per quei tempi: uomini tutti veterani e di somma bravura nel mestiero delle armi. L'armata d'Azzone and? a raggiungere l'inimico, e talmente lo distrusse, che la giornata 21 febbraio 1339 ? notata ancora ai tempi nostri nei calendari del paese, e se ne celebra la commemorazione. Dopo lunghissimo conflitto, in cui Luchino Visconti rimase ferito, pi? di tremila uomini e settecento cavalli restaron morti sul campo; duemila e cento cavalli furono presi; e fra i combattenti ben pochi furono quei che restarono illesi e senza ferita. Tanto ostinata fu la battaglia in cui, per colmo della vittoria, Lodrisio istesso rimase prigioniero d'Azzone! Federico I poneva i prigionieri sulla torre contro Crema, gli faceva impiccare, o per clemenza, loro faceva cavar gli occhi. Federico II li conduceva nudi, legati a un palo, in trionfo, poi, trasportandoli nel regno di Napoli, li consegnava al carnefice. Azzone non incrudel? contro alcuno de' prigionieri; e Lodrisio istesso, che pure meritava la morte come un suddito ribelle, fu umanamente trasportato prigioniero a San Colombano. Questa battaglia famosa di Parabiago viene riferita da due nostri cronisti che allora vivevano; da Galvaneo Fiamma e da Bonincontro Morigia; i quali, per rendere pi? maraviglioso il loro racconto, asserirono d'essersi veduto da molti sant'Ambrogio che stara in alto, e con una sferza nelle mani andava combattendo per Azzone Visconti. La chiesa milanese per? non adott? tal visione, e unicamente attribu? alla protezione del santo l'esito fortunato della vittoria; anzi ora pi? nemmeno se ne celebra la messa. Al luogo della battaglia presso Parabiago s'innalz? una chiesa dedicata a sant'Ambrogio; la quale nel secolo passato fu distrutta, per edificare la pi? grandiosa che oggid? vi si osserva. Tutte le immagini di sant'Ambrogio che hanno la destra armata d'uno staffile, sono posteriori all'anno 1339, ossia all'epoca della battaglia di Parabiago. Si cominci?, sulla tradizione di questa visione, a rappresentare il saggio, prudente e mansuetissimo nostro pastore con volto furibondo, in atto di sferzare; e si ? portata l'indecenza al segno di rappresentarlo sopra di un cavallo, a corsa sfrenata, colla mitra e piviale, e la mano armata di flagello in atto di fugare un esercito, e schiacciare co' piedi del cavallo i soldati caduti a terra. Il volgo poi favoleggi? e crede tuttavia che ci? significhi la guerra di sant'Ambrogio cogli Ariani; coi quali il santo pastore non adoper? mai altre armi che la tolleranza, la carit?, l'esempio e le preghiere. Sarebbe cosa degna de' lumi di questo secolo, se nelle nuove immagini ritornassimo ad imitare le antiche; togliendo la ferocia colla quale calunniamo il pio pastore. Nelle monete milanesi da me vedute, le prime che portano quest'iracondia da pedagogo, sono posteriori di quindici anni alla battaglia; e le mie di Azzone, di Luchino e di Giovanni hanno sant'Ambrogio in atto di benedire. Il conte Giulini ne riferisce una di Luchino collo staffile, ch'ei dice tratta dal museo di Brera: ora non credo che vi si trovi quella moneta; almeno nel museo di Brera a me non ? accaduto di riscontrarla. Come mai questo fatto d'armi si rendesse tanto celebre, e come nei giorni fausti siasi tanto distinto il 21 febbraio, e nessuna menzione trovisi fatta del giorno, ben pi? memorando, 29 di maggio, in cui l'anno 1176 venne totalmente battuto Federico I dai Milanesi; potrebbe essere il soggetto d'un discorso. Nel primo caso un ribelle che non aveva sovranit? o Stati, fu sconfitto da un principe che dominava dieci citt?; nel secondo una povera citt?, che aveva sofferto i mali estremi, sconfisse un potentissimo imperatore che avea fatto tremare la Germania, l'Italia e la Polonia. Nel primo caso si combatte per ubbidire pi? ad Azzone che a Lodrisio; nel secondo si combatt? per esser liberi, o per essere schiavi. Pare certamente che meritasse celebrit? assai maggiore la giornata 29 di maggio. Ma la fortuna ha molta parte nel distribuire la celebrit?. ? vero che una nascente repubblica nel secolo duodecimo non aveva n? l'ambizione n? i mezzi che poteva avere un gran principe nel secolo decimoquarto, per tramandare ai posteri un'epoca gloriosa.
Sin qui ho rappresentato in compendio le buone qualit? di Luchino, ora l'imparzialit? storica mi obbliga a dirne ancora i vizi. Francesco Pusterla, nobile ed onorato cittadino non solo, ma uno dei pi? amabili, pi? ricchi e pi? splendidi signori di Milano, aveva in moglie la signora Margherita Visconti, parente del sovrano, donna di esimia grazia e bellezza. Luchino pens? di sedurla, come aveva fatto a Piacenza colla signora Bianchina Landi il di lui fratello Galeazzo I; ma trov? la fedelt? istessa e lo stesso amore verso lo sposo anche nella virtuosa Margherita. La tela era gi? ordita per far soffrire a Luchino il destino medesimo di Galeazzo; se non che il cauto e sospettoso Luchino fu pronto a scoprirla e lacerarla. Tutto era disposto per discacciare con una rivoluzione questo principe dal suo trono, e si dubita che i di lui nipoti Matteo, Barnab? e Galeazzo fossero complici. Ma Luchino prese talmente le sue misure, che Francesco Pusterla, fautor principale della congiura, appena ebbe tempo bastante di salvarsi colla fuga e di ricoverarsi presso del papa in Avignone. Fin qui si vede un vizio di questo principe; ma in seguito si manifesta un'iniquit? bassa ed atroce. Non risparmi? spesa o cura Luchino per attorniare in Avignone istesso il Pusterla d'insidie e di consiglieri, i quali, con simulata amicizia, lo animassero a ritornare nell'Italia, persuadendogli che presso dei Pisani avrebbe trovato un sicurissimo asilo, e si sarebbe collocato pi? vicino alla patria per rientrarvi ad ogni opportunit?. Furono tanto moltiplicati i consigli, e tanto apparenti le ragioni, che alla fine il Pusterla si arrese, s'imbarc?, e per mare si trasfer? a Pisa; ove arrestato venne dai Pisani, che temevano le armi di Luchino, e a lui fu consegnato. Francesco Pusterla, trasportato a Milano, termin? la sua vita coll'ultimo supplicio. Un gran numero de' suoi amici diedero al popolo lo stesso spettacolo; e quello che rese ancora pi? crudele la tragedia, si fu che la nobile e virtuosa Margherita dovette, al paro degli altri, finire nelle mani del carnefice. Il luogo in cui si esegu? la carneficina fu al Broletto Nuovo, cio? alla piazza de' Mercanti, dalla parte ove alloggiava il podest?, ed ove vedesi la loggia di marmo delle scuole palatine collo sporto in fuori, da dove solennemente il giudice pronunziava le sentenze di morte. I nobili venivano ivi su quella piazza abbandonati all'esecuzione: all'incontro i plebei erano trasportati fuori di porta Vigentina al luogo del supplicio. L'industriosa sagacit? adoperata da Luchino per cogliere nell'insidia il Pusterla, potrebbe essere una lode per uno sbirro o un bargello, ma ? una macchia che disonora un sovrano. La crudelt? poi di far condannare all'orrore del supplicio una donna amata, in pena della sua virt?, ? una macchia ancora pi? obbrobriosa e vile. Luchino esili? dallo Stato i tre suoi nipoti, figli di Stefano, cio? Matteo, Barnab? e Galeazzo. La ragione di Stato forse giustificava un tal rigore, singolarmente dopo i sospetti di loro complicit? nella congiura dell'infelice Pusterla. Pretendono alcuni che Galeazzo, il nipote, fosse anche troppo intimamente unito alla signora Isabella Fieschi, moglie di Luchino, e che il bambino ch'ella partor?, ebbe il nome di Luchino Novello, per questa cagione insieme colla madre vedova passasse poi a Genova, e non entrasse mai nella serie de' nostri principi. Avr? avute quel sovrano le sue buone ragioni per tenersi lontani i nipoti; ma le insidie colle quali incessantemente li perseguitava nei paesi lontani, la miseria e la povert? nella quale gemevano sempre raminghi, sconosciuti ed erranti , son prove d'un animo niente generoso, ma anzi vendicativo e crudele. Il Corio ci dice come Luchino . E in fatti era cosa evidente che, volendosi dividere la signoria d'Azzone, i tre fratelli Matteo, Barnab? e Galeazzo avrebbero dovuto per giustizia possedere la porzione di Stefano, loro padre e fratello di Luchino e di Giovanni; e pu? darsi che l'ingiustizia che provavano, essendo esclusi nella divisione, fosse l'origine di questi guai. Gli avvenimenti sono lontani da noi, e non ci sono noti che per quel poco che alcuni ce ne hanno tramandato. L'indole di Barnab? e di Galeazzo era perversa, come dimostrarono poi; quindi Luchino avr? forse avute delle ragioni colle quali giustificarsi.
dice l'Azario.
Appena l'arcivescovo Giovanni rimase solo alla testa dello Stato, ognuno dovette conoscere che la passata sua non curanza del governo certamente non nasceva da mancanza di talento per governare, n? da indifferenza per la gloria, n? da insensibilit? per il pubblico bene. Il virtuoso principe cominci? il suo regno col far la pace coi vicini; col conte di Savoia, coi Gonzaghi, col marchese di Monferrato e coi Genovesi, posti prima in armi per le invasioni che Luchino aveva fatte, dilatando lo Stato proprio a danno loro. Assicuratosi cos? d'un pacifico dominio, la natura e l'indole sua benefica lo portarono a terminare la miseria degli esuli nipoti. Matteo, Barnab? e Galeazzo furono richiamati dall'esilio ed accolti come a principi si conveniva. Diede Regina della Scala in moglie a Barnab?, e Bianca di Savoia a Galeazzo; e festeggi? quelle nozze illustri con pompe ed allegrezze pubbliche; fra le quali vi furono dei tornei d'una nuova foggia, cio? colle selle alte, usanza che Barnab? aveva insegnata, seguendo la costumanza da lui imparata nella Francia. Oltre lo stato signorile e lieto al quale fece passare i nipoti, quel magnanimo arcivescovo si risovvenne di Lodrisio Visconti, che, dopo la battaglia di Parabiago, da pi? di dieci anni languiva in carcere, e lo rese libero. L'anima grande e generosa di Giovanni non dava luogo a quelle diffidenze e sospetti che dominavano nel cuore di Luchino. Appena un anno era passato da che Giovanni reggeva lo Stato, esteso sopra diciassette citt?, quale glielo aveva lasciato Luchino, che egli, senza umano sangue e senza pericolo, fece un insigne acquisto; e col mezzo di duecentomila fiorini d'oro sborsati a Giovanni Pepoli, compr? il dominio della citt? di Bologna l'anno 1350. Prevedeva per? il sovrano arcivescovo che questa importantissima addizione non poteva accadere senza forti contrasti, singolarmente per parte del papa, il quale, sebbene domiciliato in Avignone, sempre stava vigilante sull'Italia; e se tollerava che il Pepoli, piccolo principe, e che facilmente poteva superarsi, dominasse Bologna, non cos? tollerante doveva essere poi, passando quella a incorporarsi nella potente dominazione dei Visconti. In fatti Clemente VI mand? un ordine all'arcivescovo Giovanni, acciocch?, entro lo spazio di quaranta giorni, dovesse restituire Bologna alla Santa Sede; minacciando in caso di contumacia di volerlo scomunicare, insieme ai nipoti suoi quanti erano, e porre all'interdetto tutti i popoli del suo dominio. Giovanni non si cambi? per questo, n? pens? di abbandonare Bologna; onde il giorno 21 di maggio dell'anno 1351 il papa scomunic? l'arcivescovo e i tre nipoti Matteo, Barnab? e Galeazzo, e pose l'interdetto su tutte le diciotto citt? dei Visconti. Il Corio ci racconta come . Siegue poscia il Corio medesimo a narrarci come, essendo il papa sempre pi? irritato ed animoso contro dell'arcivescovo Giovanni, lo citasse a comparire in Avignone; e che l'arcivescovo Giovanni, preparato gi? a comparirvi col s?guito di dodicimila cavalli e seimila fanti, venisse poi dispensato dal papa istesso dall'intraprendere il viaggio, e si accomodasse in tal guisa pacificamente ogni cosa. Anche il Giovio e il Ripamonti raccontano questi fatti. Il Muratori ed il conte Giulini non prestano in ci? fede al Corio. Sono per? gli autori d'accordo nell'asserire che la scomunica e l'interdetto vennero pubblicati, e che la riconciliazione si fece ben tosto, ritenendo il Visconti Bologna in qualit? di Vicario della Santa Sede. Fra le mie monete patrie una ne ho d'oro, valore d'un gigliato, di Bologna, colla biscia Visconti, che credo battuta in questi tempi.
Free books android app tbrJar TBR JAR Read Free books online gutenberg
More posts by @FreeBooks

: Steve Brown's Bunyip and Other Stories by Barry John Arthur Kipling Rudyard Contributor Lindsay Lionel Sir Illustrator - Short stories; Sea stories; Australia Fiction